La nuova chiesa infatti, venne consacrata nel 1905 e durante il 1907 ultimata anche la sede canonica e anche i debiti a saldo. Iniziato in seguito anche l'erezione del campanile (inizio progetto 1938) e terminato nel 1955, campane e arcangelo compreso. Si capisce a questo punto l'eccezionalità dei lavori in essere per l'epoca in corso.
L'ingegnere Prof. Angelo Scattolin, che aveva frattanto ricevuto il mandato per la costruzione del campanile su cui com'è noto, non amava gli abituali progetti appuntiti tipo settecenteschi, si rivolse perciò a modelli e schemi diversi.
Sostenuto da una serie di vantaggi economici, quali il previsto passaggio della ferrovia, aperture stradali per Mestre e S. Donà, la linea elettrica S.A.D.E, l'acqua potabile, case private, commercio, transito autobus e il consecutivo aumento della popolazione, conferirono all'emergente paese il titolo di S. Michele Nuovo. Il borgo antico divenuto oramai periferico per quanto ancora il più numeroso, assunse per l'isolamento in cui si era venuto a trovare, il termine S. Michele Vecchio: appellativo che tuttora conserva. (7)
Si ricorda ancora una volta, e non già per la scarsità di memoria limitata ai paesi limitrofi, bensì perché nel vecchio villaggio vi era già costituita una chiesa settecentesca e relativo campanile (documentati) dove a seguito della prevista demolizione, venne eretta la recente canonica con gli stessi mattoni tolti dai due manufatti ai quali venne tolto l'intonaco.
(8) - Il legame di amicizia con Gaggio tra quelli citati, era il più forte e anche il paese più frequentato dagli altinati. Possedeva infatti il campo di calcio adatto al gioco per sette persone: la canicolare. All'epoca si giungeva in bicicletta per un percorso più breve del recente. Si transitava per la vecchia stazione ferroviaria di Gaggio, sino al cimitero, quindi a sinistra retro la chiesa in neanche 30 minuti. Pedalando ovviamente.
Queste località vanno appunto ricordate poiché avevano ricevuto in eredità entrambi gli edifici canonici, dimostrando a tutto vanto, una certa sicurezza su di una improbabile nuova costruzione. E da tanta tranquillità imposta da altrettanta inconsapevolezza, non si rendevano conto dei problemi sui costi che avrebbe comportato l'erezione di un campanile.
Premesso che l'antica chiesa eretta nel 1700 circa, venne in seguito abbattuta col suo campanile, su cui la popolazione, per quanto fosse a conoscenza della sua ristrettezza, non avrebbe mai previsto che tra il 1906/1907, si sarebbe deciso per l'abbattimento. All'inizio del XX sec. (1900) la chiesa si mostrava esattamente come nacque due secoli prima, limitata e angusta, priva di ampliamenti e danni strutturali. A parte la risalita di umidità sui muri interni ed esterni.
E nonostante la popolazione fosse in continuo aumento, non vennero mai applicate norme adatte per aumentarne le dimensioni interne, se non suggerite dai funzionari edili. Ma non se ne fece nulla. In ogni caso la chiesa continuava a dispetto della comunità a dimostrare il proprio limite, quale non essere in grado contenere almeno metà della cittadinanza. Causa per la quale venne a sollevarsi dai parroci intervenuti uno dopo l'altro, una serie di proposte dirette al Patriarca Card. Mutti.
(9) - Nel 1937 sorse l'idea del campanile quando Scattolin don Carlo era semplicemente vicario. Nel '38 si progettò il modello e il luogo in cui erigerlo, nel 1939 i carotaggi. Gli scavi iniziarono nel febbraio/marzo 1940.
Il diametro degli scavi mai quantificato in termini di metratura, sfiorava secondo gli operai intervistati, le fondamenta della chiesa. Considerato il dato attendibile e in ogni caso rilevabile, potrebbe stabilire misurando la corda l'intero segmento che unisce i due punti della circonferenza, cioè il diametro della fondamenta. Un rilievo dunque accessibile e che tornerà utile quando nel capitolo sesto dedicato all'altezza del campanile, si capirà che la torre doveva proseguire oltre i metri 40. (misura senza cella campanaria) Si vedrà infatti secondo calcoli previsti su progetto dell'ingegnere Angelo Scattolin, confermati peraltro da materiali inutilizzati dei quali si era già erogato il costo, collocati per anni accanto alla chiesa.
Stesso principio venne applicato sui massi di pietra durante gli scavi per la fondamenta della chiesa iniziata nel 1850 dal Card. Mutti.
Frattanto l'ingegnere Costante Gris, aggiornando il progetto di Papa Pio X prolungò l'aula di sette metri per un totale di 37 e 12 in più di larghezza. Le fondamenta realizzate dal Mutti essendo dunque minori dei 12 metri previsti (inferiori di 6 metri per lato) risiedono in parte, sotto l'attuale pavimentazione.
Costante Gris. 1843/1925. Progettò ed eresse la chiesa di Quarto d'Altino, già S. Michele del Quarto. Una volta ultimata, donò riconoscente alla parrocchia una tela raffigurante Santa Caterina di Alessandria. E' tuttora esposta all'interno della chiesa parrocchiale eretta coi emolumenti di Papa Pio X.
L'omelia tenuta a Quarto d'Altino da Bortolan don Gino durante la Messa solenne del 30 settembre 2001, (Presente il sottoscritto) ricordava in questi termini, alcuni particolari dello scavo entro cui doveva alloggiare la fondamenta del campanile. "Quando nel settembre del 1941 venni qui per la prima volta, c'era a sinistra della facciata della chiesa una grande buca. Il parroco d'allora Scattolin don Carlo, mi disse che vi doveva sorgere il campanile, ma che a causa della guerra in corso, non era possibile acquistare il cemento necessario e perciò i lavori erano sospesi. Sul fondo della grande buca s'intravedevano dei pezzi di binari incrociati, che il vostro parroco aveva raccolti e là depositati per rafforzare il terreno di origine torbosa". (10)
(10) - La gettata in calcestruzzo effettuata quattro anni dopo la visita del Bortolan, non poté nella circostanza del settembre 1941 riferire ciò che non vide quando venne chiusa nel 1945. Vennero infatti introdotti uniti alla colata di cemento un numero incalcolabile di blocchi di marmo. La manovalanza venne affidata al volontariato del paese che riempì la fossa nella medesima giornata.
Foto archivio storico Alfio Bonesso Giovanni.
Nella foto a six, si nota don Gino Bortolan in tarda età. Nell'immagine a lato, il giovane vicario del parroco Scattolin, appare in compagnia della madre. Sono ritratti a tergo della chiesa di Quarto. Alla sua sinistra si trova la canonica, abitazione nella quale visse per un breve periodo unito alla famiglia. L'ingresso relativo al vicario don Gino non era però il medesimo del parroco, bensì situato all'angolo estremo della canonica. (A destra se visualizzato da nord, da via Roma) Una ripida e rumorosa scalinata in legno lo portava nel proprio appartamento. Al di sotto dell'alloggio destinato a don Gino, permaneva dal 1907 il pollaio del parroco e relativa cantina a piano terra. La madre di don Gino esercitava con la figlia, l'attività di sarta. Nel 1942 l'intera famiglia venne traferita ad Altino.
Questi terreni torbosi si spingono sino alla vicina Claudia Augusta Agozzo, le case Colombara, lo Zero e il Pojan. Si tratta dunque e ovunque di alluvioni di terraferma".
(12) Uno studio petrografico sui ciottoli rinvenuti sul terreno torboso di Quarto d'Altino avrebbe potuto stabilirne l'origine qualora fossero stati sottoposti ai medesimi esami dei ciottoli tolti dal Sile presso Casier. Ebbene questi ultimi, risultano essere di origine dolomitica. Si ritiene quindi, che anche le ghiaie trascinate dalle alluvioni del Sile ed emerse a Quarto d'Altino, abbiano avuto le stesse caratteristiche.
(13) - Il binomio Sile-Piave comprende in realtà un unico fiume. Il Sile infatti, essendo anticamente collegato al corso principale del Piave era pertanto conosciuto con entrambi i titoli. Vedi il perché nei capoversi compilati sotto.
Nei pressi di Casier, sono state rinvenute sul fondo e ai lati del fiume Sile, composizioni di ghiaie simili a quelle recuperate durante gli scavi per le fondamenta del campanile di Quarto. Anni di ricerche scientifiche non hanno ancora svelato il mistero della presenza delle ghiaie depositate sul fondo del fiume e, tuttora non si spiega come mai un fiume di risorgiva (Il Sile) che non ne produce, come abbia potuto contenerle se non fossero pervenute da un antico ramo del Piave collegato al corso del Sile. Un collegamento che sinora non è mai stato concretamente individuato se non reso probabile ma che certamente esisteva.
Il carattere torrentizio del fiume Piave avrebbe dunque trascinato i ciottoli di origine dolomitica a Casier, sino a raggiungere Quarto d'Altino in relazione all'alluvione nella Venezia del 589 d. C. ricordata da Paolo Diacono in "HISTORIA LANGOBARDORUM". (testo moderno latino a fronte) " A quel tempo ci fu un diluvio nei territori della Venezia, quale non si crede ci sia più stato dal tempo di Noè... ci fu grande strage di uomini e di animali.... distrutte strade e cancellati sentieri..."
D'allora il Piave collegato al Sile abbandonò il proprio e antico alveo mutando direzione. Ma il terreno torboso e i ciottoli sparsi nella zona rimasero laddove le torbide e le correnti del fiume li aveva depositati. Risultati dalle indagini portano a concludere che le ghiaie del Sile a Casier provengono dalle dolomiti trasportate dalle alluvioni del Piave.
Diversamente quelle tolte dal fondo del Sile a Casier, si arrestarono molti chilometri prima, causa il peso maggiore, il volume e la quantità.
A questo punto, dovremmo anche rinfrescare la memoria a chi non ricorda o non conosce la strada consolare Claudia Augusta, aperta intorno al 15 a. C da Druso Claudio "Germanico" Generale di Augusto ai tempi della conquista della Rezia e della Vindelica.
A confermare l'antico rilievo stradale intervennero nel 1950 circa i coloni del primo gruppo relativo ai Bonesso detto "Grando" giunto a S. Michele del Quarto nel 1847. Nella circostanza, ricordava d'essersi installata nella zona detta le "Brustolade" su richiesta della nobiltà dell'epoca. (Forse la fam. Lattis o Lattes)
Altra ghiaia, sabbia e materiali diversi furono sicuramente acquistati, ma non risultano nei documenti. La società elettrica S.A.D.E pretese lire 279,20 per fornitura forza motrice (400 Watt, 120 Kw/h) - per probabile uso macchinari tipo Betoniera ed Argano.
L'attività dell'imprenditore edile oltre a realizzare le fondamenta del campanile, si rivolse anche all'interno della chiesa di Quarto. Vi eresse tre altari: la Sacra Famiglia, S. Teresa del bambino Gesù e S. Antonio. Ricavò dai muri perimetrali anche le quattro odierne cappelline. Vedi capitolo: "La chiesa e gli affreschi".
La prima pietra.
L'11 novembre 1945, il Patriarca di Venezia mons. Piazza, dopo solenne cerimonia, pose la prima pietra sulla base centrale del campanile. L'arricchì di monete correnti, di una pergamena firmata dal Cardinale e dal progettista del campanile architetto Angelo Scattolin. Il desiderio della cittadinanza quanto del parroco stava dunque per avverarsi. L'impresa edile venne scelta dal sacerdote ritenendo opportuno siglare sin da quel momento un legame possibile, tra gli operai, la cittadinanza e campanile. Propose come capomastro il sig. Antonio Prete detto "Toy Gambaro" residente in comune di Silea. In seguito vennero aggiunte altre cinque persone: due manovali, due muratori e un carpentiere.
Nonostante i problemi di ordine economico e dai limiti imposti dai rallentamenti dei vecchi macchinari, il gruppo parrocchiale portò ugualmente il campanile, dopo varie peripezie che diremo, ad un altezza pari a metri 40. La cella campanaria come si vedrà più avanti, sarà realizzata dalla ditta Franchin di Carpenedo. In seguito vi prese parte anche la ditta Scanferlato. Impresa specializzata alla messa in opera mezzo carro elevatore, i marmi pesanti sulle finestre aperte del campanile e sulle parti restanti della Loggia.
Il primo corso marmoreo della qualità "Campaniletto" costituito da 24 blocchi curvilinei, bocciardati e sporgenti rispetto al proseguo del campanile, (Costo L. 58.000) costituirono la base necessaria su cui verrà eretto il campanile. Sono di colore bianco naturale e sagomati secondo istruzioni dell'architetto Scattolin. Provengono dalla cava Astari di Conco lavorati dal sig. Emilio Zanchetta nel suo laboratorio di Pove (Vicenza). (16)
In una bolla d'acconto datata 13 luglio 1946, si scopre che Scattolin don Carlo versava alla ditta Zanchetta una piccola cifra, pari a 21 giornate di assistenza a lire 330 l'ora per posa "del primo basamento numerato", cioè del primo corso di marmo a pianoterra.
(16) - I marmi registrati sono 72 di numero - Una seconda fornitura non registrata giunse in seguito - Sono a forma arrotondata - battuti a bocciarda - qualità campaniletto - dal costo L. 157.000. Furono donati dalle famiglie su cui vennero incisi successivamente i nomi dei benefattori.
L'inverno rigido
In quel primo rigido inverno, l'antigelo sui materiali cementizi, più che rappresentare un elemento di sicurezza, costituiva piuttosto un elevato rischio per la struttura di base, motivo per cui le sospensioni dal lavoro erano frequenti. Cosicché i muratori, durante le giornate vuote si attivavano altrove. La posa dei marmi procedette comunque con lentezza, sia per la pesantezza dei blocchi quanto per i mezzi antiquati in uso dell'impresa parrocchiale.
Accantonato un risparmio di lire 118.000 dovuto al pareggio amministrativo relativo ai bisogni della chiesa, il parroco don Scattolin intendeva impiegarlo col consenso del Patriarca (Card. Piazza) che non negò, per far fronte ai primi costi del pro erigendo campanile.
Foto archivio Alfio Bonesso Giovanni. Anno 1953.
Da sinistra e riconoscibile Attilio Colombo originario di Quarto d'Altino (1922-1990) principale e autorevole artefice per la realizzazione del percorso a chiocciola.
Secondo a six. Furlan Tiziano (1922-1988) detto "Aldo" da Casale sul Sile.
Terzo seminascosto dal trave, Zanon Agostino detto "Angelo" da Quarto d'Altino. Classe 1926. All'epoca delle mie personali ricerche il sig. Zanon Angelo era vivente.
Segue Prete Silvano detto "Gambaro" domiciliato a S. Elena di Silea. (1935-1999) E' figlio del conosciutissimo capo Mastro, sig. Prete Antonio.
A lato di Silvano appare col baschetto in testa, il padre Prete Antonio detto "Toy Gambaro" (1907-1961) capo mastro dell'impresa parrocchiale.
Ultimo a destra, Crosato Luigi da Casale sul Sile. (1896-1996)
I ritardi.
In una nota a parte priva di data, si apprende il primo recapito giunto in 12 trasporti di laterizi, pari a 60.000 pezzi provenienti da Lughignano. La bolla priva di datazione, dovrebbe riferirsi al comunicato del febbraio 1952 dove il parroco Scattolin scrive:"... il trasporto mattoni è cominciato l'11 gennaio 1952..." Nessun'altro trasporto come sopra accennato venne mai registrato tra il 1947 e il 1952. Ciò significa che i primi recapiti non sono mai stati ufficialmente notificati.
Frattanto, il Ministero dell'Interno Direzione Generale Amministrazione Civile, scriveva al Card. Adeodato Piazza Patriarca di Venezia, notificando di aver assegnato al richiedente la sovvenzione in danaro stabilita in questi termini: "Ho l'onore di comunicare alla E. V. che, con provvedimento odierno al Comitato Civico di S. Michele di Quarto d'Altino, è stata concessa la sovvenzione di Lire cinquecentomila". (500.000) Il ministero però non ne specifica l'utilizzazione, va tuttavia premesso che dato l'annuncio diretto al Patriarca e la somma destinata al Comitato di Quarto d'Altino dove è in atto la costruzione del Campanile, sia legata a tale attività. Altre funzioni dipendenti ad opere parrocchiali pare che all'epoca di altrettanto importanti non ve ne fossero. Tenderei quindi per l'assegnazione della quota al pro erigendo campanile.
La notevole quantità di mattoni pervenuti da Lughignano in 60.000 pezzi, (citati sopra) non sempre costituivano quell'automatismo di rapporti corretti e sottoscritti. Gli operai dell'impresa parrocchiale ritenevano viceversa, essere parte di un dono effettuato dalla stessa o dalle stesse fornaci.
I primi mattoni documentati (tra cui pare sia inclusa anche parte delle donazioni) si sarebbero dovuti applicare rivestendo la sezione interna costituita dalla nuda vista dei marmi sagomati. Col provvedimento, venne finalmente ultimata la base, o se vogliamo, il primo pezzo rivestito in marmo del campanile.
Il dono non è comunque certo, (Si premette che non è documentato) d'altra parte il parroco, nonostante avesse ricevuto le stesse offerte da una fornace rivale, continuò con la medesima. Ma le pressioni della seconda continuarono a ritmo accelerato, finché le resistenze del sacerdote sedotto dalle continue offerte, aderì alle proposte, erogazioni gratuite comprese. (17)
(17) - Le erogazioni gratuite, non erano all'epoca ritenute un fatto di per sé scandaloso, in quanto erano parte delle rituali commesse. Si trattava però di controllare se possedevano le stesse caratteristiche di qualità-solidità, di quelle non gratuite.
Vedi per esempio il Cav. De Reali, che nel dicembre 1853 estrasse dalla sua fornace di Altino 118,000 mattoni per la chiesa in costruzione, dei quali scrive l'ingegnere Fuin "...una parte gratuita e il rimanente a pagamento ritardato e a prezzi inferiori a quelli di ordinario commercio."
Oltre alla trasparenza della fornace De Reali, del rapporto con la chiesa, dello stile, commercio, esecuzione e serietà, si deve altrettanto aggiungere che i mattoni realizzati a mano ed erogati gratuitamente, non subirono mai quegli sfaldamenti che oggi si notano sul campanile.
L'abitudine delle donazioni esercitate in vari tempi e modi, non furono certo vantaggiose per la costruzione del campanile. Lo si è dedotto nel momento in cui apparvero sui mattoni posti a dimora, quelle classiche aperture a falde e che in seguito vanno a dissolversi in pulviscoli sottili per non dire polveri.
Collocati a macchia di leopardo e non tanto per diletto, bensì per ordine di arrivo, s'intuisce dalla messa in opera, che un certo numero di mattoni strutturalmente solidi, vennero mischiati con quelli ricevuti in donazione senza distinguerne la qualità. Non sarebbe stato facile peraltro, per non dire impossibile, valutare tramite i muratori le singole proprietà dei mattoni quando manipolandoli avessero diagnosticato quali fossero i possibili sospetti. Qualora poi, fossero stati fabbricati e consegnati a carattere separato, cioè dividendo quelli di natura solida ai fragili, non sarebbero certo apparsi quei sfaldamenti a macchia di leopardo come oggi si notano. Bensì uno dopo l'altro in ordine di successione sino all'esaurimento della partita. E' dunque assodato il mescolamento tra i due elementi.
Le frantumazioni inoltre si verificano più diffusamente a nord che a sud. Logico quindi ritenere che i mattoni gratuiti posizionati a settentrione, (tramontana) non reggono alle intemperie invernali, segno dunque evidente della parziale tenuta o resistenza dei laterizi. E non reagendo ai limiti imposti dalla cottura, vanno a sfibrarsi durante l'esposizione dei rigidi inverni, delle calure estive e degli agenti atmosferici. Perciò destano molte interrogazioni a cui tenteremo dare risposta.
Secondo analisi effettuate da alcuni esperti in edilizia, (muratori) le sfaldature e la scarsa tenuta dei laterizi, sarebbero dipesi da alcuni procedimenti incompleti effettuati durante la trasformazione del materiale. Per esempio, nel momento in cui l'argilla viene collocata entro gli stampi, non si sarebbe provveduto nel contempo a comprimere regolarmente il terriccio. Una minore pressione infatti, unita ad una cottura breve o comunque affrettata, avrebbe determinato una compattezza irregolare provocando la friabilità dei mattoni.
Secondo i rilevamenti e in base alle conoscenze dell'epoca, venne anche esclusa l'ipotesi per la quale la friabilità avesse potuto dipendere dalle vibrazioni seguite dagli ondeggiamenti provocate dal suono delle campane. In tal caso l'oscillamento avrebbero dovuto lesionare tutta la circonferenza del campanile, in particolare in prossimità del vertice dove il tremolio provocato dalle onde sonore risulta più forte. Né mai queste, avrebbero potuto raggiungere i piani inferiori del campanile, laddove all'opposto appaiono le medesime disgregazioni rilevate nei piani più alti.
All'interno del cilindro, per quanto la luce confusa e ombrosa avesse solamente consentito un parziale controllo, non sono apparsi a vista d'occhio danneggiamenti di alcun genere, né guasti come quelli provocati esternamente. Segno evidente che le vibrazioni non c'entrano nulla, tranne i rigidi inverni, le piogge e i ghiacci i quali posandosi sui laterizi di minore qualità, producono in continuità le frantumazioni accennate
Foto archivio storico Alfio Bonesso Giovanni. Maggio 1955.
Da six. E' riconoscibile Gasparini Antonio detto "Toni Tonon" (1916-1975) - Segue Dalla Vecchia Roberto detto "Berto" (1920-1986) - Quindi Brentel Luigi (1905-1975) - Dal Ben Oreo detto "Folador" (1915-1978)
Le ricerche sui personaggi inclusi nella foto sono stati individuati mediante ricerche realizzate dal sottoscritto intervistando le famiglie dei lavoranti deceduti. Possiede pertanto, tutte le notizie e immagini duplicate su DVD-R. che lo stesso Bonesso in tanti anni ha rinvenuto e donato alla parrocchia.
Va pure esclusa la povertà dell'argilla prelevata in parte dal terrapieno della Via Claudia Augusta. Figuriamoci se dopo duemila anni di permanenza, soggetta peraltro al calpestio secolare, al sole cocente, piogge e tempeste e alle ingiurie d'ogni tempo, avrebbe perduto la ricchezza accumulata in tanti anni di esposizione. Non è quindi credibile, c'è dunque dell'altro.
Una domanda che aspetta risposta
Non si capisce dunque, riferendosi a strutture, fabbricati e palazzi più o meno antichi, come mai edifici nudi secolari simili ai mattoni del campanile di Quarto, possano mantenersi pressoché inalterati nel tempo o addirittura nei secoli. Per esempio quello di S. Marco di Venezia, che pur vantando 116 anni di vita espositiva non risulta contaminato dalla salsedine, né da apparenti frantumazioni, né i mattoni mostrano fragilità circostanti, semmai si presenta come fosse appena eretto.
Le stesse caratteristiche si notano anche sui mattoni dell'Abazia di Pomposa assieme alla sua Torre eretta nel 1063, per non parlare poi delle mura medioevali di Montagnana in provincia di Padova e ovunque nel mondo.
La causa del danno emergerà nel momento in cui la Torre verrà sottoposta a verifiche e controlli dalle più moderne tecnologie del momento. Imminente è infatti il restauro del campanile, e finalmente verranno accertati moventi e ragioni.
Quando notai sulla Torre, senza conoscere momentaneamente la causa e il perché mi apparve tutto d'un tratto di un colore diverso, simile per tinta come l'argento (18) correva un anno che non ricordo più. Il fatto però, riflettendo su quanto mi stava dinanzi, accadeva quando il sagrato appariva recinto dalle mura della chiesa e il rilievo di terra prodotto dagli scavi (19) per le fondamenta, occupava ancora il punto nel quale venne buttato sossopra, sia per mancanza di spazio quanto per un fattore economico.
(18) A produrre il fenomeno della tinta argentata apparsa sulle pareti del campanile, ci pensò una bella e tersa mattinata di primavera spuntata durante gli anni sessanta del novecento. E' narrata qui sotto.
Imbrattati e trascurati da quasi un decennio, conducevano e conducono tuttora, una vita per così dire assai infelice, sin da quando almeno vennero aggrediti e anneriti dall'aria inquinante, dalle piogge violente e dalle esalazioni prodotte dai circostanti comignoli. Danneggiamenti direi piuttosto frequenti in natura, inefficaci però per quanto riguarda la funzionalità della Torre che teneva inalterato il proprio prestigio. E così colpendo il simbolo della città, vennero a guastarsi con gravi alterazioni di sostanze coloranti, quella lucentezza per la quale la stessa natura aveva loro donato e che oggi viceversa, li sferza e li lorda.
Anche in questo caso come i precedenti, le ricerche e il recupero delle opere fotografiche per l'installazione dell'Arcangelo, si deve al sig. Bonesso Alfio. Ingrandimenti 40x30 e oltre sono a disposizione per eventuali mostre culturali. Sono conservate in Archivio per la storia di Quarto d'Altino.
Chi non ha avuto tempo o non ha mai rivolto lo sguardo alla Torre quando allora esprimeva il meglio di se stessa, pare difficile oggi immaginarla nelle tinte sgargianti di un tempo. Nessuno infatti, dopo il il breve intervallo dal compimento, si sarebbe ricordato delle tinte originarie se non a seguito di una ripulitura di fondo. Mutata dunque di aspetto e perduto anche la propensione al riverbero, ora dimostra tutto l'invecchiamento assimilato in poco più di cinquant'anni d'esposizione. Eppure trascurata com'è, in balia dalle cicliche avversità dei tempi, si pone tuttavia tra le opere più importanti della zona e sopravvivendo allo stato di abbandono, rimane in attesa che qualcuno se ne prenda cura.
Osservando casualmente l'alba di quel giorno, non certo abituale durante il corso dell'anno, se non per la luce primaverile, improvvisa e abbagliante proiettata da levante sui miei occhi, per cui infastidito, mi spinse a rivolgere lo sguardo dal verso opposto, dove per l'appunto sorgeva il campanile. E volgendo le spalle al sole nascente, vedevo esterrefatto la Torre che si stava stranamente e lentamente dipingendo.
Lo stupore cessò nel momento in cui compresi che il bagliore giungeva dallo spuntare del giorno e che per tale effetto moltiplicava i giochi di luce trasformando le tinte originarie ottenute termicamente. Anni dopo venni a capire il perché quella strana luce proiettata sulla Torre aveva efficacia di mutamento su delle pareti allora pulite, come dire non infangate dalle lordure attuali.
Foto archivio storico Alfio Giovanni Bonesso. Copyright dell'autore.
Lo stesso splendore si manifestava anche sui nudi mattoni, eppure, al di là della propria gradualità, apparivano meno accesi, molto meno di quanto il sole sferzandoli a metà giornata toglieva loro l'incanto della mattinata. Giunti poi alla volta del tramonto, tutto si riportava alla normalità, quella di sempre. A fissarlo intensamente, incuteva anche un certo senso di grandiosità quando al termine della giornata, nell'istante in cui la Torre viene colpita dalla calda luce del digradante crepuscolo, pareva sollevarsi dal suolo ed offrirsi in uno spettacolo eccezionale.
In realtà, dimostrava e dimostra tuttora, sia per potenza che per dimensione, tutta la propria eccellenza e mole. Se poi vi aggiungiamo anche il crepuscolo che animando la Torre in una travolgente decelerazione visiva ancorché sorgente di elevazione, fa ben sperare che generi nell'uomo, ideali, sentimenti e sensazioni diverse.
Il fenomeno della sollevazione si potrebbe osservare solamente trasferendosi lungo lo scorcio della laguna, quando appunto il cielo per effetto del sole calante si congiunge alla terra e l'orizzonte si fa evanescente. Ecco allora che la Torre in quei brevissimi istanti, pare sollevarsi dalla terra e dominare il territorio circostante.
Visione ottica? Fenomeno? Combinazioni naturali? Testimonianza del sovrannaturale? Per rendersi conto dell'eccellenza, che trasmette peraltro sensazioni intense, basterebbe proiettarsi entro lo specchio d'acqua fornito dalla laguna, utilizzando qualunque navicello... purché a portata di mano.
Il colosso di Quarto si erge visibile trai tetti della città su cui gli effetti cromatici delle tegole tendenti al rosaceo e, le circostanti campagne tinte di verde, si uniscono in un solo elemento guidato dai vari fattori esterni.
Lo scarico dei mattoni e le polveri di cemento in chiesa.
Tanta cautela però scivolò ben presto in danno. Un danno al quale i fedeli amareggiati dall'insolita posizione, obbligava l'ascolto della messa in un contesto nel quale la deconcentrazione era piuttosto diffusa e, per una ragione molto semplice.
Indossava vesti sgualcite e aggiustate sin da quando aveva iniziato l'attività pro erigendo campanile, causa per la quale il parroco dovendo risparmiare all'osso e la perpetua Vittoria: 1^ cugina del parroco, consapevole dell'impegno che si era assunto, ne rammendava gli indumenti, anche i più riservati, accomodando e riutilizzando anche ciò che non era più riparabile. (21)
Attivato dunque il fuoco per mezzo di due aste opposte recanti altrettante micce accese, dalle quali vedemmo all'istante il bagliore intermittente del combusto esplodere in leggeri e continui crepitii laddove le faville ronzanti attorno, prevaricavano il fruscio scatenato dalla miccia. La fugace fiammata calcolata sulla base della lunghezza, illuminava la serata, già di per se pulita priva di nuvole, in un chiarore pressoché diurno, esteso solamente agli autori dell'impresa e al luogo della mascalzonata. Sedotti dal fascino delle vampe e animati dalla fulminea prestazione della miccia, ci abbandonavamo uniti al piacere dello stare insieme, in pensieri fantastici dove la trasparenza del cielo stellato ci accompagnava nell'immaginazione più alta. La contentezza purtroppo durò ben poco, quando improvvisamente, intervenne la visita sgradita della perpetua che, temendo dessimo a fuoco anche il fasciame posto lì accanto, tentò allarmata d'inseguirci minacciandoci col rastrello in mano. Ma noi eravamo già lontani, oltre il limite di sicurezza.
E dovendoli affrontare, fece di necessaria virtù l'acquisto di giovani animali da cortile affidando il compito della crescita ai contadini. A fine stagione venivano ceduti da persone di fiducia, oltre al ricavato delle uova. In alcuni appunti si trovano citazioni d'ogni genere, vedi esempio"... vendita di un maiale di quintali 1.40 a lire 7,10 il kg.... "ricavo dalle offerte in polli e tacchini lire 521,20" ... e ancora, "ricavato dalla cerca di frumento lire 420".
Tutto dunque giostrava sull'abilità del sacerdote che non mancava comunicare gli introiti al Consiglio Pastorale. L'entrata di cassa veniva poi riportata sui bollettini mensili.
Nel mese di agosto 1952, il parroco comunicava mezzo il consueto bollettino parrocchiale la seguente nota: "Il campanile ha finalmente ricominciato a salire. I lavori sono stati iniziati dalla ditta Franchin di Carpenedo, e speriamo che la bella opera possa essere ultimata..." (Il bollettino però, non annunciava i licenziati dell'impresa parrocchiale)
Vedi le travi in legno collocate sulle due aperture ritenute le più pericolose. In seguito, anno 2017, vennero sostituite mezzo elementi in acciaio inox.
Foto archivio storico Alfio Giovanni Bonesso. Copyright dell'autore.
Per quanto riguarda l'odierno visitatore ignaro del danno ma spinto da un gruppo di persone uscito frattanto dal campanile, udito quindi le analisi interessanti della comitiva, dal piacevole riscontro lagunare e dalle verdi campagne d'intorno, si domandava rivolto alla Torre su cui intendeva salire sul poggio più alto, quale altra caratteristica, oltre alla bellezza del panorama, cos'altro in più gli avrebbe potuto riservare. Ebbene, se ne rese conto come tanti altri in seguito, che a metà circa del camminamento allorquando calpestando il punto più alto della lesione, avvertiva la strana sensazione di sentirsi sollevato dal suolo come avesse ricevuto una spinta dal basso verso l'alto.
La ditta Franchin veniva frattanto sospesa dall'architetto e invitato il parroco alla riassunzione degli operai espulsi. Nel comunicato del settembre 1952 don Scattolin non a caso scriveva: " I lavori sono stati fermi per una settimana e mezza, dato che si è dovuto cambiare la squadra dei lavoratori. Il 13 agosto veniva ripresa l'attività normale."
Dell'episodio preferì non farne cenno, e anzi i lavoratori della parrocchia furono immediatamente riassunti con tanta discrezione di don Scattolin, che non esitò ad affidarsi alla loro riservatezza. Nel comunicato dell'ottobre 1952 scriveva ancora: "Il campanile in data 20 settembre 1952 ha raggiunto l'altezza di 32 metri." Dell'incidente non ne fa ovviamente parola.
Ovvero, l'effetto del rientro che aveva per scopo il salvataggio del campanile.... e lo misero in salvo.
La contentezza dell'impresa parrocchiale causata dalla riassunzione, finì per credere, fosse stata un'opera di mediazione piovuta dal cielo (Ben grave qualora fosse rimasta senza lavoro) e non solo per aver sistemato l'errore del Franchin, quanto anche perché nel frattempo raggiungeva nel tardo autunno 1953, quota 40 metri. Una meta irraggiungibile se si considera l'allontanamento che di fatto li aveva tagliati fuori dal primato, ma che concretizzò ugualmente.
La cerca dei metalli riguardava ogni persona di buona volontà, anche i battaglieri ragazzi della parrocchia che senza chiedere nulla al parroco, si misero in azione. Ne venne scoperto molto, anzi ne trovammo sulle rive del Sile, presso la Cellina S.A.D.E. e nei d'intorni della stazione ferroviaria. Il ferro non mancava anche se mal si adattava per la fusione col bronzo . (Venne comunque ritirato) Si trovava ovunque, anche tra i residuati bellici inerti della recente guerra mondiale. La moltitudine di masserizie ferrose riempì improvvisamente di gioia l'animo di don Scattolin, meno irritato quel giorno di quanto lo avevamo notato durante il sinistro sul campanile.
Il 16 marzo 1953 venne fissata sulla porta maggiore della chiesa, lo stemma del patriarca card. Roncalli. (Vi sono a proposito alcune foto probanti) Il dipinto si deve al veterinario e abile pittore dott. Ugo Vitaliani che, incaricandosi del compito a titolo gratuito, eseguito peraltro ad opera d'arte, fece risparmiare al parroco alcune centinaia di lire.
Il sussidio e la contentezza di mons. Scattolin
Il mattino del 5 maggio 1957, mons. Roncalli patriarca di Venezia (28) durante la visita pastorale effettuata a Quarto d'Altino, dispensò anche la Cresima ai fanciulli nati tra il 1948/49. In seguito, incuriosito dai problemi emersi durante la costruzione del campanile, chiese tra i tanti comunicati del parroco, di quanti gradini fosse composto il percorso. E poiché la domanda conteneva una certa ostilità nel praticarli, udito che non ve n'erano, notato inoltre la favorevole condizione climatica, decise per l'ascesa sino alla cella campanaria. La richiesta aveva comunque un fine del tutto personale: scrutare dall'alto della torre il Campanile di Piazza S. Marco. Lo si capì comunque dopo. (Segue sotto)
(28) Per l'occasione Scattolin don Carlo, ringraziò personalmente il Card Roncalli per l'appoggio al contributo relativo al 1953, offerto dallo Stato Italiano.
Foto archivio storico Alfio Bonesso Giovanni, in data File 15/04/2014. Copyright dell'autore.
Non è fusa in un blocco unico, bensì composta in lamiere di acciaio inox, sagomate a mano, battute e unite a chiodi ribaditi e fusi. L'interno è completamente vuoto, sorretto da un insieme di elementi cilindrici che reggono l'intera struttura.
Foto archivio storico Alfio Bonesso Giovanni. Ottobre 1958.
Circa 40 anni dopo, la statua venne a bloccarsi, al cui restauro si cimentarono alcuni specialisti affiancati dal sottoscritto il quale documentò fotograficamente l'evoluzione. Il materiale fotografico è a disposizione per eventuali futuri restauri.
Il sig. Simon Benetton ricordava, nonostante fosse andata a vuoto la richiesta, quando da giovinetto s'intratteneva col padre affaccendato intorno all'Arcangelo in fase di realizzazione, la cui quota in altezza, si mostrava dinanzi al figlio, meno della metà, salvo i tubi di collegamento derivati dall'estremità del capo.







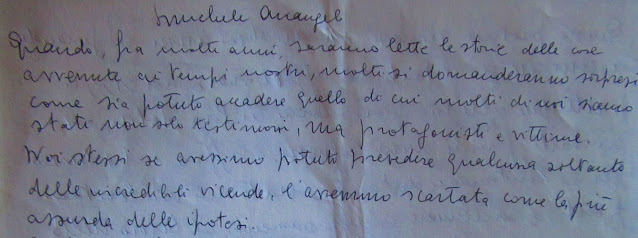



























Nessun commento:
Posta un commento